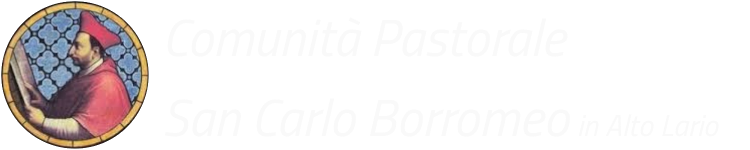In questo anno in cui siamo stati costretti a rallentare, e a guardare in faccia alla morte che tutti ci attende, è riemersa dal profondo una domanda esistenziale che le mille corse della vita e la cultura dell’adesso e del tutto e subito hanno opportunamente narcotizzato, perché è una questione inquietante fino al punto da generare angoscia dentro di noi.
Questa domanda è il primo trauma dell’uomo, il suo primo pianto, vissuto nella nascita: si esce dal grembo e da subito si deve affrontare, senza capirlo, il tema della destinazione: dove sto andando?
Dove mi state portando? Che fine faccio? Non è un problema dei neonati, ma di tutta la vita. Ancora oggi non so mai veramente dove vado a finire: che ne sarà di me? Tante cose mi spaventano.
Alla tavola dell’ultima cena la questione riemerge con prepotenza: riguarda Gesù, ma riguarda direttamente anche tutti coloro che stanno a quella tavola, che nell’annuncio della fine di Gesù intravvedono la loro propria fine: e che ne sarà di noi? Il turbamento è generale.
Lo comprendiamo se ripensiamo ai nostri lutti più cari: ci domandiamo, certo, che ne è di questa persona cara che mi lascia? Ma ci domandiamo anche, che ne sarà di me, ora che resto solo? E certi di noi restano fermi al giorno del lutto, prigionieri del loro dolore, perché non vedono un domani e un senso per l’oggi.
Questo dolore paralizzante non è da meno di quella sorda angoscia per il domani che congela tante persone in una eterna adolescenza, dove il desiderio dominante è quello di uscire di casa – che poi cresce, e diventa il desiderio di una dimora – che, non risolto, non permette di crescere, di assumersi la responsabilità di scelte definitive, o di impegnarsi per una vita piuttosto che per un’altra.
Accomuna anche la decisione di abdicare al compito educativo degli adulti nei confronti dei giovani, che vengono lasciati allo stato brado del “fai come ti pare”, perché non c’è nulla di promettente da proporre per cui valga davvero la pena di vivere.
Ed è compagna di quella disperazione piena di una mancanza di senso generale al proprio esistere che esplode tragicamente in gesti folli o in quelle scelte “medicalmente assistite” e “legalizzate” con cui porre fine alla propria vita. Gesù – che vede l’ombra della sua fine avvicinarsi velocemente a Sé – si propone ai suoi con un invito, che forse, nell’attuale contesto, vale la pena di capire bene.
«Non sia turbato il vostro cuore: Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore».
Gesù parla del Padre, perché è nella Sua casa che c’è la risposta alla nostra inquietudine nativa, come dice il Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia» (Sal 62,2).
Per cogliere la bontà promettente di questo invito dobbiamo tornare all’immagine dell’infante che nasce: ciò che calma il suo pianto disperato è il ritrovare una relazione nell’abbraccio di quel padre e di quella madre di cui riconosce il battito rassicurante del cuore. Il luogo in cui ci si sente “a casa” non è un posto, bensì una relazione ritrovata.
Tommaso, colui che deve sempre verificare se una cosa è autentica, fa la più logica delle domande: «Non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gesù non dà una mappa. La strada che ci indica è Se stesso: «Io sono la via», non è né il Calvario, né il Santo Sepolcro. La Via è una relazione, quella con il Padre, ed è anche la nostra Verità, e la nostra Vita. “Io conosco la via perché conosco il Padre – dice Gesù – e tu conosci la via al Padre perché conosci me”.
Basta quello. Non serve imparare a memoria tutte le curve e i bivi. Non serve assicurarsi contro tutti gli imprevisti.
Quando conosciamo Gesù, quando abbiamo memoria di Lui, quando viviamo il nostro Battesimo e ci sentiamo “inseriti in Cristo”, allora qualsiasi cosa ci riserverà la vita, vale la pena di viverla, finanche di “darla”, offrendola.
Anche la morte. La regola è restare con Lui, costi quel che costi. Allora si arriva sempre.
Perché la meta a cui intimamente aneliamo non è un luogo: è un posto – una dimora – nel cuore di Dio Padre.
don Andrea